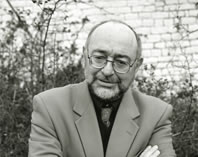
In occasione del cinquantesimo anniversario del ’68, intendiamo aprire un dibattito su Pelagos Letteratura sul momento più significativo della nostra storia dal dopoguerra ad oggi.
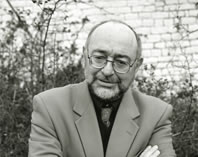
Non c’è stato nessun periodo più esaltato o condannato: mancano, a nostro parere, ricostruzioni e giudizi equilibrati.
Ho vissuto il ’68 e gli anni attorno nella piccola Urbino, che costituiva però un punto di riferimento per un’area molto vasta che andava da Rimini a Pescara e comprendeva larghe zone dell’entroterra toscano-appenninico, marchigiano ed umbro. Allora non esistevano facoltà distaccate da Bologna, Firenze, Siena. L’Università di Urbino aveva una sua precisa importanza ed era meta di delegazioni studentesche di tutta Italia.
Mi ero laureato da poco, insegnavo alle magistrali, a avevo un rapporto continuo con l’Università come collaboratore di varie cattedre umanistiche. Alle mie spalle una serie di iniziative di tipo sia politico che culturale. Nei primi anni Sessanta ero stato fra i fondatori del Circolo Luglio ’60 che aveva organizzato una serie di manifestazioni a sostegno dei movimenti democratici spagnoli, contro la guerra in Vietnam e tanto altro.
Essendo stato in delegazione in diversi paesi dell’Est, avevo potuto costatare con i miei occhi non solo le “lacune”, come allora si diceva, ma il fallimento pressoché completo del socialismo reale. Dunque ero immunizzato da ogni fede verso quella dittatura del proletariato alla quale si rifaceva la contestazione.
Gran parte del Movimento Studentesco riponeva una totale fiducia nella Cina, in Cuba, nel Vietnam: l’URSS veniva contestata, ma si era pienamente riabilitata la figura di Stalin sulla scia delle posizioni cinesi. I ritratti di Lenin, Stalin e Mao campeggiavano nel più duro dei Movimenti Studenteschi, quello milanese di Capanna e compagni. Anche Cuba era un punto di riferimento importante: Che Guevara vissuto come rivoluzionario, libertario e martire, ancora più di Fidel.
Altro mito era il Vietnam di Ho Chi Minh e i piccoli guerriglieri Viet Cong, mito amato anche dalla sinistra tradizionale. La politica vietnamita oscillava tra Cina e URSS.
Tutto inizia con una serie di richieste da parte degli studenti universitari, e successivamente anche delle medie superiori, riguardanti la didattica e il rapporto docenti- allievi. Si pretende un diverso spazio ed una maggiore libertà di espressione e di autonomia. Nascono gruppi di studio senza l’apporto dei docenti, incentrati quasi sempre su Marx e sui classici del marxismo, come Lenin e Mao. Mao in particolare viene studiato e celebrato come l’oppositore al revisionismo, di cui l’URSS incarna il massimo rappresentante in campo internazionale e il PCI in campo nazionale, ma da noi, e in particolare ad Urbino, i marxisti eterodossi, come Adorno e Marcuse, non trovano certo lo stesso seguito.
È soprattutto sul piano del costume che avvengono i massimi rivolgimenti: le ragazze iniziano a parlare in assemblea e il tabù della verginità, ancora tenace nel nostro paese, inizia a sgretolarsi. Insegnavo alle magistrali e la mia prima lotta fu quella di imporre in classe la presenza di una ragazza incinta: la studentessa era stata allontanata in quanto cattivo esempio per tutte le compagne. Iniziarono gli scontri fisici con i “fascisti” e le dispute ideologiche sempre più feroci all’interno del Movimento Studentesco.
Mi fermo qui: queste mie brevi annotazioni intendono essere un appiglio, quasi solo un pretesto, per iniziare, a 50 anni dal ’68, una discussione che terrà conto anche dei libri, dei saggi, degli interventi, dei romanzi e dei racconti usciti su questo discusso periodo della nostra storia recente.
Umberto Piersanti

Del “Cupo tempo gentile”; il ’68 di Umberto Piersanti sotto forma di romanzo.
Una delle teorie sociologiche più aggiornate sui movimenti collettivi, validata da cospicue ricerche storico-empiriche, sostiene che i gruppi sociali minacciati dal declassamento sociale e quelli in rapida ascesa sono gli animatori originari di ogni movimento collettivo nelle moderne società complesse e stratificate ; anche il ’68, forse soprattutto il ’68, convalida questa teoria: una piccola e media borghesia che si sente sempre più smarrita di fronte all’avanzata competitiva delle classi popolari-si pensi all’effetto che ebbe, sulle famiglie borghesi, vedere i propri figli adolescenti accanto ai “ragazzi del popolo” nella scuola media obbligatoria per tutti- e una compagine sociale in formidabile ascesa: i giovani; il movimento del ’68, però, ha una peculiarità: la classe che teme la degradazione sociale e quella che conquista, rapida e prepotente, la ribalta della Storia, in larghissima parte coincidono: sono borghesi e giovani gli studenti che occupano le università, formano collettivi e organizzano manifestazioni di piazza; il nucleo fondante del movimento del ’68 risiede, al di là delle adesioni alle varie ideologie di ispirazione marxista-leninista, in questa contraddizione: il soggetto sociale che più si stava affermando, i giovani, era costituito dagli appartenenti ad una classe che già da qualche tempo sperimentava con angoscia la diluizione della propria identità, la borghesia. Il protagonista del romanzo di Umberto Piersanti, Andrea, soggiace ad una duplicità – mi piace analizzarlo estendendo, un po’ surrettiziamente, all’esistenza del singolo l’applicazione degli strumenti sociologici-, vive una divaricazione sempre più ampia tra il suo far parte del movimento e il suo divenire un uomo compiutamente adulto; come membro del movimento, nel corso del romanzo, declina sempre più: il suo “declassamento” come militante è tanto più inesorabile quanto più chiara è la sua ascesa dallo stato di ragazzo a quello di giovane uomo. Andrea scioglie gli assoluti, quasi in un’avventura prometeica, dei dogmi e degli slogan di quel cupo tempo- la dittatura del proletariato, la rivoluzione culturale cinese, la lotta di classe, ecc.- con la gentilezza del paesaggio urbinate, col calore e la baldanza del desiderio erotico, con la rivendicazione pugnace del senso e del valore dell’arte e della poesia. Lui aspira ad un tempo più gentile, ma non sa come realizzare questa aspirazione e non riesce a prefigurare quale sarà l’assetto di una società più giusta, eppure…eppure le stagioni, i cicli della natura, le “opere e i giorni” dei contadini, le sere e i mattini che si contendono, con le loro luminosità rivali, le Cesane, tra i monti ed il mare; ed ancora, i colori ed i sapori delle donne ed i ricordi dell’infanzia nei quali Andrea scivola magari mentre salta un fosso o contempla degli arbusti; ecco, in questo continuo, sempre incompiuto, trapassare dalla natura all’eros, dal paesaggio all’arte, al ricordo, Andrea diventa vivo, vero, insomma esiste….