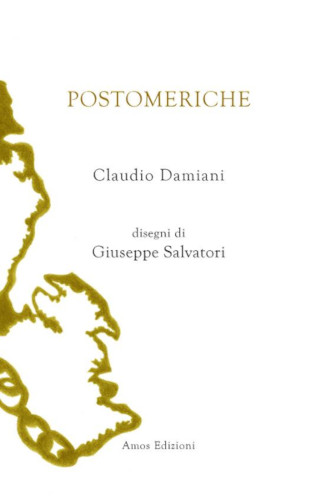
di Rossella Frollà
Claudio Damiani
Postomeriche
Amos Edizioni, 2024
Torna la parola chiara, oraziana, immediata di Claudio Damiani a dettare la realtà umana e la Bellezza che la nutre. E questa benedetta realtà sempre nascente, mare violento, indomabile, passione che ci divora se non la incateniamo e ci costringe a seguire sempre più oltre la Verità, questa universale realtà che va oltre le nostre misure e ci spinge al Mistero, viene narrata dalla parola nella sua capacità d’essere, nelle domande e nella crescita che compie per farsi sostanza eletta. Il poeta dà voce alla Terra, a questo Ambiente Divino in cui l’uomo è Valore Assoluto ma anche colui che provoca in esso una indicibile agonia. E tornano le guerre in questo nostro tempo di guerra e tornano le armi di Achille tanto desiderate da Aiace, «posero fine al loro lungo cammino/lucide e polite come appena forgiate/[ … ]/Tu Aiace le sentisti e gioisti profondamente nel cuore/[ … ]il mare gliele aveva portate alla fine».
La Bellezza eroica non sa coprirsi, si può combattere nudi con lei sola, senza armatura. La vera armatura per il poeta è quella Verità che dentro di noi si affina da secoli, quella qualità originaria su cui poggia il pensiero che si evolve nel corso degli anni, quel bene primigenio che giace nelle alte profondità dell’essere e che niente può scalfire, neanche il tempo. La Terra e i luoghi si fanno Bellezza sovrasensibile, quasi allegorie botticelliane. Quel bene torna a galla come le pastiglie nel bicchiere. I beni e le risorse interiori che forgiano questa armatura quotidiana salvano dal flusso esistenziale, dall’ansia insoddisfatta di felicità, dall’urto col mondo, dalle connotazioni forzose rispetto al dato, vale a dire dal fraintendimento, dallo stato d’animo che risponde solo all’atto quando le emozioni prevaricano la ragione. Questa armatura poggia sugli «schinieri» del mondo, sui valori che ci difendono dai colpi della vita «e sulla testa poni l’elmo che fa paura». Poi quando la parola arriva al dettaglio e lo scruta, sentiamo pian piano svanire nelle nostre mani le forme particolari di tutto ciò che stringiamo fino a restare soli con l’essenza di tutte le consistenze e di tutte le unioni. E, dunque, dall’idea che si incarna nella parola compaiono due vie: l’una porta all’essere intenzionalmente colpito, stupito dal mondo, l’altra giunge a ricostituire una realtà immediata, astante. Il processo creativo si basa sulla flagranza esistente, tolta o sospesa, e dunque sul qui ed ora che si contrappone alla memoria. L’arcobaleno che prende le due sponde e recupera le cose e i luoghi primigeni è la felicità più piccola ed è come se esistesse ininterrottamente.
Così la parola che risponde al dettaglio delle cose, al «canto di cicale» scende nelle regioni profonde della gioia, lì, dove gli abissi custodiscono il primo sguardo sui paesaggi, le esigenze dell’amore, del sentimento e del mistero. Qui l’esperienza della quiete e del ricordo si nutre di orizzonti di senso radicati in una continua apertura di emozioni ai luoghi e al sé che si appaga in essi. Il senso di questa raccolta è la felicità non desiderata ma colta sul fatto, nella memoria. La nostalgia è appagata da quella goccia costante del ricordo e dalla consapevolezza del bello che non abbandonano l’uomo. In questo prato rinasce luminoso il senso della vita come partecipazione al destino di gioia e di speranza. È certo che la via del silenzio consente al poeta di andare alla ricerca della linfa segreta e misteriosa della vita, del desiderio che racconta l’amore, la speranza. Il caso, il destino, la Provvidenza fanno parte del sistema, dell’Ordine Ontologico che detta le sue regole, come la natura umana detta le sue guerre. La vita detta le sue ferite e risale il sé mentre l’io trova le forme strutturali duttili e piane, dove la metafora omerica fa la sua narrazione, coglie la realtà. Le rêverie trasportano le fragilità e le scorie dell’essere, la preminenza dell’anima sul dato letterario di base.
La parola non blocca l’astanza sul nascere ma la lascia respirare fino a che qualcosa diviene significante e una nuova creatura, l’epifania, vola alta sopra il pensiero e l’esperienza. La parola è quel che noi siamo, rigenerata, secondo quell’Unità poetica che si fa centro dell’umanità e si è costituita ad oggetto: «Chiunque è vivo, chiunque respira/combatte in modo identico agli altri/e in modo identico cade sul terreno/facendo rimbombare fragorosamente l’armatura/sollevando molta polvere/e, spesso, mostrando impudicamente le vergogne.». La forma visibile è quella della realtà secondo un motu proprio dove la nostalgia luminosa e la tragedia latente in ciascuno concedono di indicarci quell’origine comune e quel destino, quella differenza che parla alle menti e nei cuori e che non si annulla ma mantiene e abbraccia l’un l’altro, senza abolire la distanza. In questa raccolta poetica, di mente e cuore, i contrari non lacerano: «Bisogna avere un cuore di ferro/come Ulisse, per vivere./Penelope è davanti a noi e piange/e noi dobbiamo tacere, non possiamo dire niente,/non possiamo commuoverci./È tutto chiaro/eppure non possiamo rivelarci.». La luce non ha perso la sua indipendenza che abbaglia la bottiglia polverosa e rende la coscienza del poeta tangibile a se stessa, visibile al nostro occhio. Il confronto tra il poeta e la realtà riacquista sempre circostanze nuove, riscoperte amate, e le immagini si fanno come emanazioni luminose del colore nel flusso improvviso con cui sorgono dalla coscienza. Sganciata da ogni intento mimetico-riproduttivo, da ogni legame con la percezione reale, l’immagine-luce si fa qualcosa d’altro, e un velo bucolico si stende sugli elementi realistici e fantastici. Le epifanie scorrono leggere, spontanee, mai ingenue, in un’ambientazione paesaggistica che a volte si fa protagonista e altre fa da sfondo alle vicende umane, «il cielo sta zitto e alto,/luminoso, quasi trasparente.».
E torna il luogo primigenio, l’isola d’Elba, che si incarna in una Bellezza quieta, sublime, ispira ammirazione, commozione. È la memoria di un godimento composto, non per questo meno intenso. È lo Spirito della Bellezza che consacra coi suoi colori pensiero e forma. Si approda a una tristezza luminosa dove arde silenziosa la vita per sempre: «Ai focolari è rimasta la cenere/e la legna è bruciata a metà». Tutto sembra essere scolpito nel Silenzio e quando la vita si fa lontana si va nella propria interiorità, dentro la propria solitudine senza perdere il contatto emozionale con le cose e le persone. Lo Stimmung, lo stato d’animo, che ne segue è un fülhen, un sentire affettivo che riconsacra il bene dei luoghi. Tutta la Bellezza vien su come un bene che scorta e cura e alleggerisce quella nostalgia che non si fa dolore morale o speranza infranta ma memoria piena. In essa il mare della solitudine lega le esperienze ai luoghi e la parola riempie di sé quelle ferite interiori che ogni emozione intensa del passato porta fatalmente nel suo lascito nostalgico. La memoria del poeta si incammina nelle stanze isolane, «vorresti restare in quel luogo per sempre/e farti cullare.». Qui la nostalgia si nasconde nel cuore della tristezza, ne resta quasi imprigionata; il desiderio è di ritornare a casa, in quella luce risognata: «C’è un’isola, dentro di lei una casa,/nella casa un tavolo, con dei cesti sopra,/si sente un suono come di telai,/ogni cosa è posata con cura/come per sempre,». Da questa sfumatura alta che resta, l’anima non si spezza anche quando saluta le emozioni più care e rimangono solo «le imposte (che) sbattono senza posa». I volti della Nostalgia e del Silenzio non si dissolvono nell’isolamento ma nell’astanza della parola. In essa si concretizzano, e in questa solitudine non si cade, non si precipita, perché si fa lontana da ogni separatezza.
Ogni emozione raccolta si fa il bene di quella Bellezza che attrae e non delude, si fa risorsa che non tace e tutto rilancia la speranza e attenua la morsa dell’angoscia. Le risonanze guariscono il desiderio e il moto interiore torna come scelta. Qui la solitudine si fa risorsa e può filtrare le scorie dell’angoscia. Tristi e abbaglianti i suoni tornano dai luoghi friabili, liberati dalle spine della nostalgia, si fanno parole fiammeggianti che rievocano metaforicamente i temi omerici. In questo corpo di immagini e di parole, l’autore ha riunito le poesie di varie pubblicazioni. Torna La miniera (Fazi, 1997) dove la bellezza dà slancio e ferisce quando non è più posseduta, ci sembra di «camminare per le vie della poesia latina». La Natura nel suo dettaglio parla del Tutto e un paesaggio arcaico, pastorale dà voce tenera, forte e pulita al verso. Il mondo viene rimpicciolito, guardato da vicino per capire come contiene il mondo grande.
L’idea si incarna nei luoghi campestri, nella contemplazione dell’atto eroico, nella Bellezza dell’Ordine che rimuove ogni volta gli attacchi del caos e sempre la realtà si fa resistenza. Il senso della Terra trasuda in ogni verso come in tutta la lirica del poeta. In questo Ordine dove ogni cosa trova il suo posto e niente è meno di qualcos’altro, il cuore degli esseri resta sempre giovane, come i sedili della casa di Filemone e Bauci: «una casa semplice di contadini,/bianca, ordinata,/con dei gerani alle finestre.». Lo sguardo prensile è pronto a cogliere il desiderio come possibilità di rendere visibile l’ascesa del sé, l’infinito che abbiamo dentro. È questa la rappresentazione di una vita piena, felice verso l’invisibile che pur si attende. Questa opera contiene le verità delle tante raccolte, e sono come le tante perle tra i sassi di un fiume. La domanda ultima è: «Cosa c’è là?» Forse gli angeli non conoscono quest’ansia, vengono dipinti sempre felici e quella “Bellezza del Bene” noi non l’abbiamo per intero; in noi le figure del nulla producono l’ansia di conoscenza e quella del mistero. Se l’intuizione dell’autore va verso la dimensione nascosta delle cose e risponde con l’innocenza della parola al loro richiamo, lo slancio che suscita il problema dell’ignoto porta alla luce l’indicibile e l’invisibile: «Ora in quell’isola verso cui andiamo fluendo/silenziosamente mi sarà svelato il mistero/o forse lì troverò la morte, senza che niente mi sia svelato.». Penelope è la guida dell’autore verso questo mistero. È la vita che tesse il suo futuro che ci è dato solo di immaginare: «Ora vorrei essere accanto a te con la mia mano nella tua/aspettando la morte, senza sapere niente,/senza sapere niente di niente,/essendo completamente ignorante.». Il linguaggio è narrativo e ritrae la Bellezza con le tre parole di Tommaso D’Aquino: claritas, integritas, consonantia. Tutto si gioca sull’equilibrio dei toni, sulle espressioni chiare, brevi, incisive travalicando le anguste misure di quel dettato che non gioca sulla libertà del verso.
Ma alla fine, per l’autore, la vita è una strada o un vicolo cieco? Il valore intrinseco che si scorge in questi versi è nel Fenomeno umano, là dove l’amore appassionato per la vita ci fa decidere ogni volta di andare più lontano.
L’opera fa parte della collana diretta da Arnaldo Colasanti e contiene disegni di Giuseppe Salvatori.
