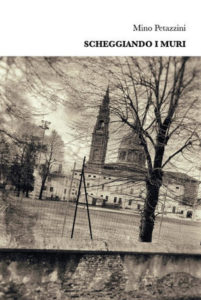
Pelagos Letteratura. Rivista diretta da Umberto Piersanti
Ad un certo punto della propria vita si arriva a riecheggiare il passato, a ripopolarlo delle persone, delle immagini, dei paesaggi che l’hanno contornato e definito; tutto questo è, direi, la cosa più normale del mondo, qualcosa che si inscrive nella naturale progressione del proprio tempo, e l’eco di quel suono passato, se posto a confronto con quello che si vive, cambia le proporzioni (e la percezione) della propria quotidianità. Non è solo una questione di bilanci, anche se questi non mancano mai, neppure quando il momento del rammemorare non si era ancora proposto con la necessaria forza (non peso, non amo questo termine) – con la durezza, vorrei anche dire – degli anni.
Non solo un bilancio, quindi, ma pure una raccolta a sé di quel tempo, una riproposizione sempre poetica, nel senso più lato del termine, della vita passata. Quella poesia, in genere, viene conservata nel proprio intimo, non si traduce in null’altro che in un ricordo più o meno patetico (nel senso di un pathos che lo anima e lo ravviva). Quando però la poesia esce dal suo senso esteso e si fa precisa parola creatrice di sentimenti, immagini, di una visione che trascenda i bilanci o la nostalgia per qualcosa che si è perduto tra le nebbie del tempo; quando il ricordo è precisamente la materia di un poeta (la sua scrittura), allora il rammemorare acquista un tono, una densità, una forza affatto diversa.
La poesia, è ben noto a tutti (o, almeno, dovrebbe esserlo), è rammemorazione, ne è l’arte – quando sia effettivamente poesia, non la patologia di un qualche sentimento da esprimere (straziare, espellere?). Chi cerca di fare poesia rammemora continuamente, trae dalla memoria tutto ciò che (gli) serve; quello che riuscirà a farne, manipolando, mescolando, travisando, riadattando, definirà propriamente il suo lavoro, lo renderà appunto poesia – se questo era il suo intento. E quindi ecco Scheggiando i muri, uno tra gli ultimi libri di Mino Petazzini (Bohumil, 2019), nel quale possiamo leggere alcuni momenti di una vita raccolti e addossati contro un muro, quello del passato, come scheggiature che lo hanno inciso.
Se poesia è, come sopra ho appena affermato, sempre rammemorazione, cosa rende particolare questo libro (questa poesia) da ogni altro lavoro di Petazzini? Elenco almeno tre motivi, e uso questo termine per la sua assonanza, per me non casuale, con qualcosa che rammenti un suono, un canto, un refrain – senza per questo voler costringere la poesia di Mino nel soffocante angolo della sola canzone, come giustamente sottolinea Robaey nella sua postfazione al libro – il suono, il motivo dominante, la sua eco che arriva dal passato e che sosta sulla poesia di Petazzini è (mi piace definirla come) una tagliente austerità nel definire e comporre – forse sarebbe meglio dire “ricomporre” – i sentimenti che la animano.
I motivi dunque: discorso, lingua, visione: tutti e tre concorrono, in questo libro con una particolare determinazione, verso quell’austerità di cui sopra; proprio perché la materia del passato in genere è sempre vischiosa, rammemorare può diventare una trappola mielosa della perdita, può agguantare come nelle sabbie mobili. Petazzini opera con serietà e avvedutezza: seziona i sentimenti, li depura dalle scorie, ne sviluppa così il loro fluire verso un’infinità del discorso che vuole intraprendere, le immagini che prendono corpo e vita sono date con ruvida grazia, e la visione non si scompone mai in un melenso “ahimè”, sostiene invece la rettitudine dello sguardo non dolente, solo scheggiato da quei ricordi di cui si è cercata la traccia incisa e sbiadita dal tempo. C’è sempre, nella poesia di Mino, una composta dolcezza della visione che propone, ma (lo ripeto) in questo libro la trovo proposta particolarmente.
Durante la lettura di questo libro, ho un’immagine che mi si presenta ogni volta, quella di un tardo pomeriggio che si sta ravvolgendo nella sera incipiente, quando i colori del paesaggio – qualsiasi esso sia – si combinano in molteplici sfumature che (a me) richiamano il violetto eliottiano. Perché la sera? non certo per una questione anagrafica – sarebbe una sciocca banalità, lo ripeto, ricondurre questo libro a una dolenzìa per ciò che inevitabilmente spinge a quella fase della vita, alla sua sera. Di questo avviarsi, della vita voglio dire, personalmente ne ho una concezione nietzschiana, ed è la stessa che ritrovo nel sottotesto di questo libro, ciò che appunto sostiene il suo discorso, il fluire delle parole che legano assieme lingua e visione. Quindi il tramonto e la sera non come compendio di una fine, con conseguente nostalgico ricordo di ciò che non è più; invece l’irriducibile svolgersi del buio verso la luce del mattino – per quel che dovrà ancora essere.
Indicativi di questo, mi paiono i versi che ritroviamo a p. 46, nel testo che inizia con Cammina a piedi nudi, laddove l’autore elenca una serie di quotidiani gesti, posture, variazioni su pensieri fantastici, che l’occhio del fanciullo vagheggia, osserva, immagina, trasfigura e conserva per tutti i mattini che ci saranno nella sua vita: «Sfiora l’erba come un soffio. / Volteggia sopra i tetti sul tappeto volante. / Spacca in due la luna. /Dirada la nebbia. / Recupera le armi. / Sorridi ancora, ricorda, taci. / Sali le scale. Vai in bagno. / Toccati la fronte, sputa, vomita / Nella musica di sottofondo. / È la vita che ti incide, ti sbozza, / Non ci possiamo fare niente.»
Certamente quello che il tempo incide, che la vita scheggia, ci forma, modella sere e mattini, giorni e anni; ogni minimo gesto vi concorre; e trattenerne la consistenza può significare riuscire a portarne il valore oltre la sua apparente leggerezza – fare questo è appunto tramutare quelle sensazioni (quei sentimenti) nel giubilo della poesia, di questa poesia, se «Ogni cosa può essere sfiorata / Acciuffata, posseduta / Vinta o perduta.» (Di sera il bambino si ferma, p. 91).
Una lingua poetica ferma, asciutta, precisa nelle descrizioni fino al minimo particolare, perché è in questo che per Petazzini risiede la conoscenza di ciò che (ci) avviene o, perlomeno, una sua possibile chiave, la quale apre alla mescola della vita. Sintomatico, secondo la mia lettura, il testo che inizia con Nella scatola luminosa (p. 29), un delicato compendio di ricordi raccolti secondo una ragione che (mi) fa pensare alla scepsi gnoseologica, l’esperire della propria vita come conoscenza di cosa possa esservi oltre quel fluire del tempo: «Il sole racconta tutt’altro. / Mamma, papà, nonna, zio. / Auto, radio, giradischi. / Grano o granoturco ancora verde. / Ortensie, mughetti, narcisi. / I giardini di Casalmaggiore. / Dove il cielo si perde in chiacchiere. / Le galline discutono con le anatre. / Il temporale è un suono assoluto, / Che chiude la giornata. L’elettricità / È speranza. La speranza nutre un po’ di libertà. / Di questo sono orgoglioso.». Voglio porre l’attenzione, a sostegno di quanto appena detto, sulla reiterata interruzione del verso col punto fermo, una forma tipica del verso di Petazzini che, oltre la naturale andata a capo, rafforza una certa sospensione dell’immagine che quel verso propone. Qui la annoto come particolarmente significativa, poiché questo fermo punteggiare, a mio parere, sottolinea l’unicità dell’immagine che il verso ci riporta – il punto fermo la racchiude, la conferma prosciugata da ogni strascico esistenziale che l’aveva prodotta, la definisce un’esperienza atomizzata, in nessuna relazione se non con se stessa, capace di espandersi libera e sola; ogni verso diviene così la tessera di un mosaico che si compone nello svolgersi dell’intero discorso che il libro contiene.
Infine il suono che contorna la sua poesia: cosa avviene di quella eco cui accennavo all’inizio? personalmente (e paradossalmente) la considero muta; voglio dire che la musica di Mino, che ha composto e ancora compone la sua vita, resta solo per lui, con questa non c’è consonanza, non potrebbe, la poesia di Mino (giustamente) non la cerca; se si resta nell’ambito di quel sentimento poetico intimo (definito secondo il suo senso lato di cui dicevo all’inizio), ogni consonanza e, direi, consolazione può essere lecita; ma non è questo il compito della buona poesia. Emerson, nel suo travolgente saggio Fiducia in se stessi, afferma che «In ogni opera di genio noi riconosciamo i nostri pensieri respinti; essi tornano indietro verso di noi ammantati di una certa maestà altrui»; Petazzini, con la sua poesia e massime con Scheggiando i muri, fa esattamente quello che ogni poesia (che sia tale) dovrebbe: ci permette di risentire il nostro suono rimosso, e quei sentimenti che propone si svelano a noi come qualcosa che avevamo dimenticato di sentire e che ora, nuovamente, ci riempie.
Salvatore Jemma
