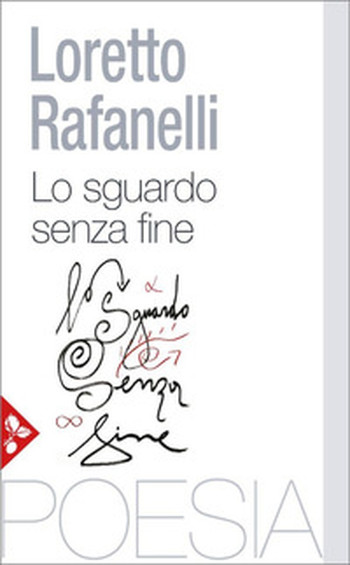
Per i tipi della Jaca Book è stata da poco data alle stampe l’antologia “Lo sguardo senza fine” del poeta Loretto Rafanelli.
Vi è presente una summa del suo percorso poetico, dalla prima raccolta che risale al 1987, “I confini del viso”, all’ultima silloge del 2021, “Ad ogni stazione del viaggio”.
L’antologia, quindi, ricomponendo un percorso ultra decennale nel solco della parola, dipana e rimarca, attraverso le quattro sezioni da cui è composta, quelli che sono i temi peculiari dell’autore.
Innanzitutto, appare evidente come il centro della poetica di Rafanelli si ponga nel cuore dell’Appennino tosco emiliano e al centro del centro, nucleo vitale e pulsante, è collocata Porretta. Luogo della memoria e delle radici, “Porretta/ è un salto,/una lama a un colmo nevaio,/a un tiepido ventre”. Culla e riparo, dunque, ma anche eco di “passi su e giù per la via/ del centro, coi tanti nomi nei negozi/persi nel vuoto”. Porretta si trasfigura in madre che tiene “il filo della storia, il filo/ della via delle grandi stagioni” è il centro gravitazionale da cui si parte e a cui si torna, il varco che si apre sulla montagna o che degrada a valle, verso la pianura.
Da qui, da questo locus conclusus che assume spesso i contorni del mito, della memoria e del sogno, il poeta intraprende il proprio cammino lirico che lo conduce sul versante toscano, sulle tracce degli ermetici fiorentini, ma che raccoglie soprattutto la lezione di poeti dell’area pistoiese come Bigongiari e Carifi.
Alcuni versi recano lo stigma luziano, la sua humanitas e quella accettazione delle vicende della vita sublimate dall’esperienza della morte, intesa come trapasso del limite e approdo ad un “Tempo nuovo”, un interrogarsi “a mani giunte e occhi bassi” nell’attesa di una risposta: “Osservare, intatti. Ancora, sempre./Non chiudere all’invocazione, alle parole,/al decoro del mondo, alla balbuziente/visione. E non consumarsi nel buio/del grido”. Così sembrano riaffiorare alcuni topoi e suggestioni linguistiche già presenti nel Luzi delle raccolte “Dal fondo delle campagne” e “Nel magma”; pare, infatti, materializzarsi in Rafanelli la stessa “malinconia dell’essere” che si relaziona con il mondo, con l’altro da sé filtrato dalla propria coscienza, una coscienza che ricuce il tempo al suo fluire e l’io alla sua memoria:
e si vede il punto più estremo del mondo,
e il punto dell’argine, e il respiro dei giorni,
e l’andare continuo dei volti,
e l’amara assenza del ritornare,
e l’incontro con la sfinita visione del mare,
nel magma delle radici, nelle tante
patrie, nella mia patria.
Un itinerario che è anche esplorazione e sopralluogo, una cartografia dell’anima, con coordinate geografiche che lambiscono luoghi distanti tra di loro ma che il poeta trasforma in un unico spazio interiore, un microcosmo osservato da dietro il vetro di una sfera. In questo modo ogni luogo si fa stazione di un viaggio che è stato percorso ancora prima di essere intrapreso, poiché il poeta/viandante lo affronta sempre con lo stesso sguardo misto di inquietudine e meraviglia. Dai “solcati tunnel di ferro e carbone” lussemburghesi all’“intrico di acque” veneziano, dall’“antica terra nera” dell’Italia meridionale al grattacielo Chrysler di New York, fino ai “frammenti oscuri” sudamericani.
Luoghi che si fanno pretesto di scandaglio, accomunati dalla necessità di essere considerati da una prospettiva che li inquadri oltre la semplice apparenza. E in questo Rafanelli si rivela poeta attento e rigoroso. Il suo sguardo interroga sempre l’assenza, si fa profondo e rintraccia i filamenti, la radice con la sua fitta tessitura sotterranea di rimandi di significati e, come si diceva in precedenza, con tracce sparse ma evidenti della poetica ermetica che attingono, oltre a Luzi, anche a Betocchi. Come nel caso dei seguenti versi di Betocchi nei quali si possono rintracciare modalità retoriche e lasciti introspettivi che il poeta di Porretta fa propri: “ma soltanto la vita che a nulla s’asseconda/se non al proprio esistere: eternità non eterna/perché è soltanto la vita, e non altro che vita/nel cui principio si consuma, provvisoria, una fine”.
Dunque, un’eziologia dell’esistenza, quella di Rafanelli, che la memoria preserva dal tempo e rende il tempo stesso una zona franca, sospesa tra la realtà e il sogno: “È una nenia che rinfocola la memoria,/che rinnova le insenature del sogno,/ora proprio ora che tutto/si respira lontano come la vita”.
Poeta del dire piano ed esatto, del palpito e dell’attesa, dell’arte del decifrare i segni incisi sul legno, vigile di fronte a ogni sussulto della Storia, intento a scrutarne ogni remota piega. La sua poesia è civile in quanto non si sottrae al proprio mandato, non arretra, non si fa mai servile accondiscendenza, assolve al compito di testimonianza anche lì dove l’abisso ci fissa e inghiotte: “Sul calanco a voce sbiancata/affacciato sul vento, sgrano i nomi./Efrem Benati, 17 anni, Nino/Bonfiglioli, 18, …, tante pietre/sporte sul ciglio grigio. Morti/per continuare a tracciare la linea/azzurra degli alfabeti”; la sua poesia si fa civile proprio lì dove la Storia continua a assediarci e tormentare: “scavo nelle ossa con mani fasciate/di morte, e guardo gli occhi/persi nelle foto, martoriati/da muti aliti di pietra. È che ho/nel passato scandito Bergamo di vene d’oro e vedo ora tra le mura/antiche il sangue rappreso/nelle branchie di ferro”.
La poesia di Loretto Rafanelli fa leva sulla forza intrinseca della parola, si affida alla concretezza dei nomi, li interroga per scrostarli dal silenzio che li attanaglia, ne scandisce le sillabe anche quando, come nei versi dedicati alle vittime dell’eccidio di Sant’Anna di Stazzema, quegli stessi nomi si illuminano per rivendicare la propria presenza e si ribellano alla stretta di un suono indistinto e magmatico: “I nomi della luna piena di mezza estate,/uno a uno sepolti dal battere/di acciaio. Ventri squarciati. Leggiamoli uno a uno…”. Sono nomi che tentano di risalire la china dell’oblio quelli della bambina che “piano e compunta va alla messa”, l’ombra dei fratelli che scorre nel fiume, i piccoli compagni che “corrono in una girandola di grida”, i quarantatré giovani messicani assassinati nella scuola rurale Isidro Burgos di Ayotzinapa: “Devi pensare/alle cose nel solco del loro solco,/agli orti delle stagioni morte,/ai palpiti sfioriti nelle carezze,/ai giorni che battono i rintocchi./Allora dici: persone. E puoi dire/ancora: persone. E le ombre/che gravano, le togli/dal fondo che confonde/il mare”.
Si fissa in questi versi di alta intensità l’agguato di un presente minaccioso e oppressivo che non ha futuro senza il passato. Ecco, quindi, che Rafanelli crea nuovi equilibri tra sfera interiore e mondo esterno. E lo fa associando i volti ai luoghi, che quindi assumono una doppia valenza: una simbolica e l’altra metastorica. Se da una parte i luoghi rappresentano la sfera degli affetti personali, essi diventano anche – così come ne “La camera da letto” di Bertolucci – la fenditura che consente al poeta di ricordare e narrare vicende di migrazioni e di povertà di migliaia di uomini e donne che quei territori hanno attraversato: “E sicuro ora li rivedo passare/nelle scintille armate degli occhi mentre/guizzano tra le immagini infinite/di un paese. E poi Pistoia da dove i miei,/come cercatori d’oro, arrivarono a Porretta,/nella vallata della via stretta/dal freddo, risolta nella Piazza/in un’ansa ferrosa e buia”.
In questo modo il poeta tracima dall’epopea familiare nella Storia.
Dicevamo dell’influsso di Bigongiari e Carifi sulla poetica di Rafanelli. Il tempo e la memoria, ad esempio, vengono declinati secondo stilemi cari ai due poeti pistoiesi.
Il tempo, assimilato ad un vortice che insidia una problematica quiete – “un grande vortice imbocca paesi e città” – è una metafora assai frequente nell’opera di Bigongiari: “il vento ha preso possesso del giardino,/penetra per la rosta un vento fine ch’è parola…”. Così come l’immagine della memoria/teca che conserva i lacerti di un tempo felice, barlume di una fanciullezza ormai lontana – “I bimbi corrono sui campi/e i mattini nella pelle/allineati scorrono/in una nudità senza parole.” -, ritorna anch’essa nei versi di Bigongiari: “Ecco un bambino/felice che risale quelle scale,/ecco il bambino che conduce armenti/per valli desolate su un crinale/tra ciò che era e quello che sarà”.
Ma è soprattutto Roberto Carifi il nume tutelare della poesia di Rafanelli. È Carifi ( “Il Maestro dell’anima”) che lo guida per ricomporre le tessere di quella epopea familiare destinata a farsi canto: “… in questa via minuta di Pistoia, la città dei/padri, dove la tua scrittura/è il canto estremo”.
Se nel nucleo incandescente della poesia di Carifi intercettiamo i volti delle persone care, soprattutto la madre del poeta, non sarà un caso se in questa antologia di Rafanelli la parola madre gode di una più diffusa occorrenza rispetto ad altre, così come i termini che rimandano al suo campo semantico.
Tutto matura e germina da sé, anche nel dolore più cupo dell’assenza: ”Dire di questa attesa. Della madre/composta tra i ceri nel suo umile/ bianco vestito da sposa. Dire di una luce/improvvisa che non cogliamo./ Di un fiato che spande il suo ordine./Una misura della vita che non sappiamo,/una dolcezza che giunge”.
C’è nei versi dell’autore una pietas che lo invita ad attribuire al proprio dolore una valenza universale, una sorta di agnizione che gli fa accettare la perdita della madre come se si trattasse di un dono: “mi dici:/< ci fu il tempo delle parole/e il tempo del passaggio nel deserto, >/ e il tuo sorriso mi avvolge caldo/come un dono”.
Tra due estremi, quindi, si muove in questa antologia la poetica di Rafanelli: il dolore, la cui origine è arcana e misteriosa e l’amore, unico antidoto alle lacrimae rerum.
E lo sguardo del poeta riconduce la fine al suo principio, la vita all’oscurità e viceversa, nel loro eterno fluire:
Vita che giungi nel segreto dell’attimo
che ordini le trame e i vasti lungomari,
che porti gli estremi sipari,
che attraversi i secondi nella fissità
del nominare, qui nello spazio di una stagione
che va dal senso del precipitare
al sorriso lieve come il gioco
di un bimbo, osserva le coordinate
del nostro viaggio, conta le pause delle notti,
guarda l’eccedenza e i grani
del raccolto, quell’atto dell’incontrare
o l’estrema solitaria
oscurità.
Valentino Campo
.
