La colpa e il suo senso ci isolano
come la parola senza la sua lingua
(Roberto Marconi, 2021)
“Il chiaro del bosco è un centro nel quale non
sempre è possibile entrare; lo si osserva dal
limite e la comparsa di alcune impronte di
animali non aiuta a compiere tale passo”.
María Zambrano
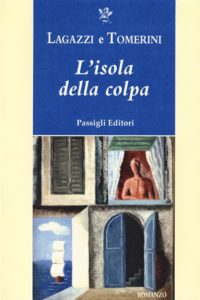 È un romanzo circolare quello di Tomerini e Lagazzi “L’isola della colpa” (Passigli Editore 2020) come l’iter di un essere umano: in conclusione si ritorna, anche solo con la mente, all’incipit: “Ci sono cose che devi fare, anche se ti costano il sangue”. Perché vivendo si muore ai contrasti (chiamateli come volete: giorno e notte, bene e male, yin e yang, ecc.), come il grande abbraccio del muro bianco di un convento, dove si svolge principalmente questo consistente racconto (il luogo è dedicato a Sant’Anastasia, da una ricerca scopro che il nome vuol dire “colei che nasce a nuova vita” come vorrebbe la Resurrezione e proprio ora porto a compimento quanto scritto, dove il 15 aprile è della venerata l’onomastico), anche se per le vicende che si susseguono e per la forte transitorietà lo spazio primariamente sembra più un tempio, il quale può affrancare o all’opposto rabbuiare/abbacinare di riflesso col sole (tale da tentare di spegner ad esempio la speranza d’un raccolto). Tra fede e incredulità, nel libro, si leggono storie che spaginano le vite degli interpreti, i quali sono in continua visita alle istanze sostanziali e insolute dell’esistenza che l’ascolto, la contemplazione, tra certezze e tentennamenti, diventano capitali. In un passo un protagonista afferma la grande difficoltà a credere ma “è meraviglioso osservare come gli esseri votati al sacro abbiano cercato di racchiudere in templi, celle o cappelle, in sale o cripte vibranti dell’eco di campane o di gong, inchiostri o eremi, in apsidi, sacrestie o battisteri ciò a cui non si può alludere nemmeno con le idee più acute della filosofia o con le metafore più audaci della poesia perché forse non è altro che il respiro della verità inattingibile”.
È un romanzo circolare quello di Tomerini e Lagazzi “L’isola della colpa” (Passigli Editore 2020) come l’iter di un essere umano: in conclusione si ritorna, anche solo con la mente, all’incipit: “Ci sono cose che devi fare, anche se ti costano il sangue”. Perché vivendo si muore ai contrasti (chiamateli come volete: giorno e notte, bene e male, yin e yang, ecc.), come il grande abbraccio del muro bianco di un convento, dove si svolge principalmente questo consistente racconto (il luogo è dedicato a Sant’Anastasia, da una ricerca scopro che il nome vuol dire “colei che nasce a nuova vita” come vorrebbe la Resurrezione e proprio ora porto a compimento quanto scritto, dove il 15 aprile è della venerata l’onomastico), anche se per le vicende che si susseguono e per la forte transitorietà lo spazio primariamente sembra più un tempio, il quale può affrancare o all’opposto rabbuiare/abbacinare di riflesso col sole (tale da tentare di spegner ad esempio la speranza d’un raccolto). Tra fede e incredulità, nel libro, si leggono storie che spaginano le vite degli interpreti, i quali sono in continua visita alle istanze sostanziali e insolute dell’esistenza che l’ascolto, la contemplazione, tra certezze e tentennamenti, diventano capitali. In un passo un protagonista afferma la grande difficoltà a credere ma “è meraviglioso osservare come gli esseri votati al sacro abbiano cercato di racchiudere in templi, celle o cappelle, in sale o cripte vibranti dell’eco di campane o di gong, inchiostri o eremi, in apsidi, sacrestie o battisteri ciò a cui non si può alludere nemmeno con le idee più acute della filosofia o con le metafore più audaci della poesia perché forse non è altro che il respiro della verità inattingibile”.
Si può scrivere (vivere) se non ci fosse qualcosa che ci cattura? Qui il colpo è femminile (una graziosa bambina, una donna che cela un passato grave, una madre morta, una superiora irrigidita, una ragazza per colmare un vuoto e una molto invidiata da sfruttare) e la narrazione prende spunto dalle tante peregrinazioni, stavolta in un’isola greca, di Daniela (artista, illustratrice, novelliera e iniziatrice d’eventi culturali: https://danielatomerini.com/) con chi divide la sua sorte, Paolo (narratore, che conosce bene gli strumenti della scrittura – trovati fin da giovanissimo dentro un cilindro –, saggista, tra i maggiori e originali critici in circolazione: https://paololagazzi.com/): nella prassi un incontro tra due arti, in una spietata traversata negli abissi dell’animo dove, pensando a Conrad, i personaggi attendono di confidarsi o di vuotare il sacco.
Questo libro potrebbe distinguersi in autobiografie a mo’ di Confessioni o in un giallo a tinte noir, per i misfatti sottintesi, denunciati ma nascosti (come di chi ha paura dei film horror, ma li fissa ugualmente o chi s’accorge in ritardo che gran parte delle favole, che ci hanno abitato l’infanzia, sono cruente), pertanto c’è sempre un confronto tra opposti che convergono: vita monastica e vita libertina, l’amore innocente in una classe delle elementari e quello deludente in una camera d’albergo, tra verbosità e silenzio, tra chi scrive e chi legge, tra una coppia nella vita e i due interpreti della storia (nell’affannata rincorsa a una terza fondamentale protagonista).
C’è una suora, di quelle che paiono “una statuina del presepe, una di quelle contadine anonime e insignificanti che stanno a certa distanza dalla grotta santa perché sono rimaste in fondo alla scatola, e siamo stati incerti fino all’ultimo se inserirle come figure di contorno”, così imbevuta fino in fondo di Vecchio Testamento, che anche se non lo conoscesse ne sarebbe talmente affogata (e un pozzo compare nella narrazione, anche questo fonte d’innesco del male: del senso del possesso, della rivalità, della lascivia, ecc.), vacilla fino alle viscere nella descrizione del destinatario delle sue preghiere e anche delle proprie fattezze/nefandezze “a volte ho pensato di essere un incrocio tra una bambola sventrata e una volpe o tra uno spaventapasseri e una lucertola. Forse una parte della mia anima è fatta di segatura trucioli, di cose di scarto, e insieme è tesa e aguzza come gli occhi di un ramarro o di un gufo? In realtà non sono mai riuscita a capirmi e nemmeno a guardarmi negli occhi: se c’è un oggetto che detesto è lo specchio: avrei voluto romperli tutti, gli specchi, infrangerle, calpestarli, sbriciolarli… Per fortuna nel convento non ce ne sono. Ma ciò non puoi impedirmi di tornare spesso a considerare quanto radicalmente il mio destino sia stato segnato dalla bruttezza – e dalla bellezza… e quanto ciò sia misterioso e assurdo, o semplicemente ingiusto. Questo pensiero ha il potere di spostare in modo violento le angosce generate in mezzo al silenzio di Dio. Arrivo a pensare che forse un dio c’è, ma non è affatto quel padre amoroso che Cristo ci ha annunciato: è quel dio malvagio, quel demiurgo crudele, sadico che alcuni cosiddetti eretici dei primi secoli della chiesa consideravano il solo vero responsabile di tutti i mali del mondo. Chi se non uno come lui può aver progettato dei lineamenti come i miei e un’anima tortuosa, spastica come la mia?”. D’altronde l’esame, ad esempio, di un qualunque monaco non è prima credo con Dio ma con l’ateismo, con l’inesorabile esercizio del nulla più infinito, trovarsi solo a fare i conti con sé stesso, con i propri attaccamenti e per giunta anche con i vezzi dei confratelli; come avviene nell’esperienza della notte oscura degli asceti, che esplode già da quando l’incoerenza della religione, l’infedeltà dei devoti iniziando dagli ecclesiastici, prorompe nei meandri del quotidiano, ma da lì si può almeno scegliere se arrivare alla piena conoscenza del divino o del malvagio.
E c’è dall’altra parte della religiosa un uomo, alla ricerca disperata di una verità, nella descrizione viene paragonato a “un cacciatore di leoni rimasto col fucile scarico in mezzo alla giungla”, che fa “scarne domande” in “un disperato desiderio di trovare conferme”, invocazioni in cui si percepisce “il senso di smarrimento di un giocatore d’azzardo senza fortuna”.
Ogni decifrazione accurata compone il destino della storia.
La suora prima dei voti, tra le varie vicissitudini, aveva con un baratto acquistato un pappagallo, sembrava felice per i detti proferiti (“A domani”, “Come va?”, “Forza!”, “Attenta!”, “Chi ha tempo non aspetti tempo”), che l’animale ripeteva, ribadiva in pratica ciò che la faceva sentire amata, parole più vere della banalità del senso o dell’ipocrisia di chi le può pronunciare. Quei termini reiterati assumevano nella traduzione circolare (tramandati nei tempi, ridetti da lei al pappagallo e da questi riportati) un senso di paradossale appartenenza, quella di cui per per tutto il romanzo viene latamente denunciata la mancanza: una profonda adesione a qualcosa che ha valore d’identità. In questa storia anche i nomi sono contati, non compaiono quelli degli autori facilmente, come riusciamo a dimenticare gli appellativi dei personaggi, perché il punto è dove l’umano e i suoi concetti si spingono, dal trasgredire al crimine (che può avvenire quando non s’impara a vivere appieno la solitudine) e tutto questo non ha fondo se non nella continua, spasmodica ricerca della parola che può sì dannare ma anche salvare (in una delle precise citazioni all’interno del libro, presa dalla grande Flannery O’Connor – che ho conosciuto nella letteratura grazie all’affetto che provo per Robert Walser –, lei sottoscrive: “L’inferno, un inferno vero, è la nostra unica speranza. Il peccato conduce a Dio un buon numero di persone che altrimenti non lo raggiungerebbero”) una parola scavata, come quella potenziata in lunghi discorsi sibillini di un “frate” di strada che incontra la donna quando ancora era laica. Questo essere le fa da guida spirituale e nei suoi ultimi attimi di vita, perenne ai bordi, sentenzia a lei e ai suoi seguaci, come se tutto nascesse e morisse lì, appunto nella parola che apre e chiude:
“Seppellitevi nella gola di Dio”.
Se potessi scegliere non darei alle stampe questo mio scritto per avere ancora tanto da dire e da stare zitto o meglio come ambiva Walter Benjamin, vorrei scrivere soltanto di citazioni e quelle all’interno di questo libro (da Sofocle a La nube della non conoscenza, da Nabokov a Bloy) basterebbero per un trattato sulla durata e per invogliare anche a conoscere, ancora altro, di chi ha scritto questo romanzo. Una volta chiuso ho sentito che aveva l’aria d’essere venuto fuori da una scultura, dentro, nascosta, la colpa, ma non più quella del Libro ma quella perdutamente umana, che fa diventare presto disumani.
Ma cos’è allora la Redenzione? Forse capire che l’amore arriva tra le spine, atterra in completa immersione nella natura?
La terza protagonista è la figura cristica (spesso descritta come un fantasma, un essere altro) che pian piano capisce di chi essere, ma dubita umanamente e grida il suo “perché”. Se c’è un riscatto questo giunge nella morte (sovente riposta da noi nell’oblio, seppur essa onnipresente. Una volta era così naturale che in una casa, in una comunità il ciclo della vita era l’unico governo umano; ora invece si muore lontani – casa di riposo, ospedali, ecc. – come su di un’isola, appunto, da soli. E se invece vivessimo veramente qualche momento ogni giorno?) o l’affrancamento è meglio nel darsi completamente agli altri, questo a conti fatti è il fine.
Eppure basterebbe un passo. Ancora un passo e sarebbe il Respiro.
