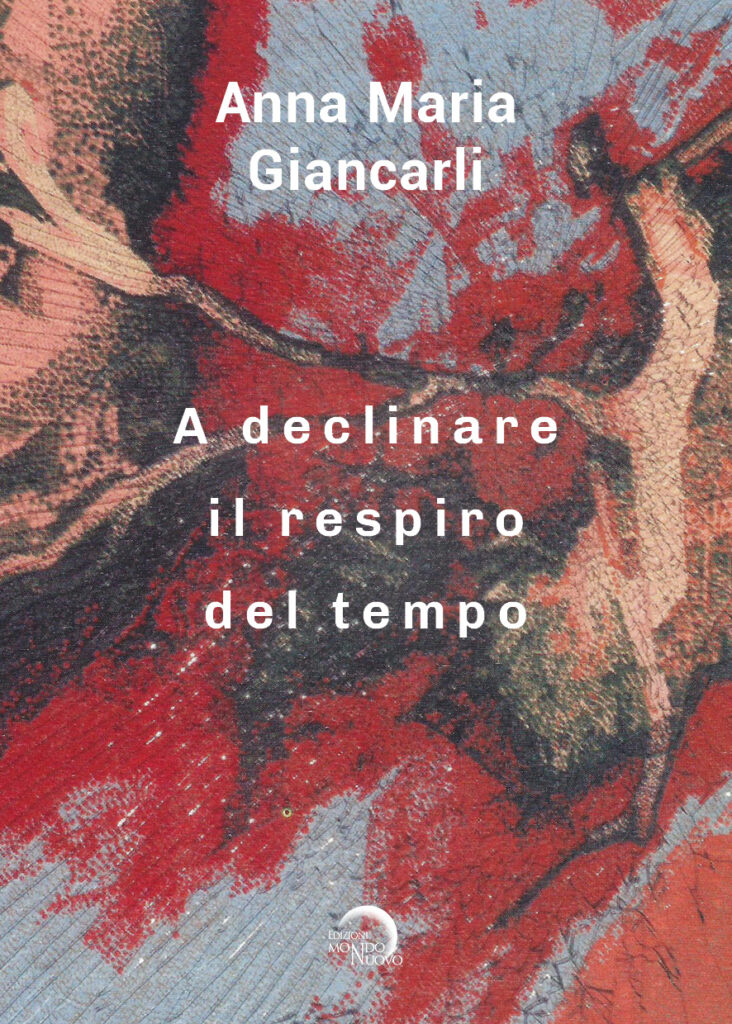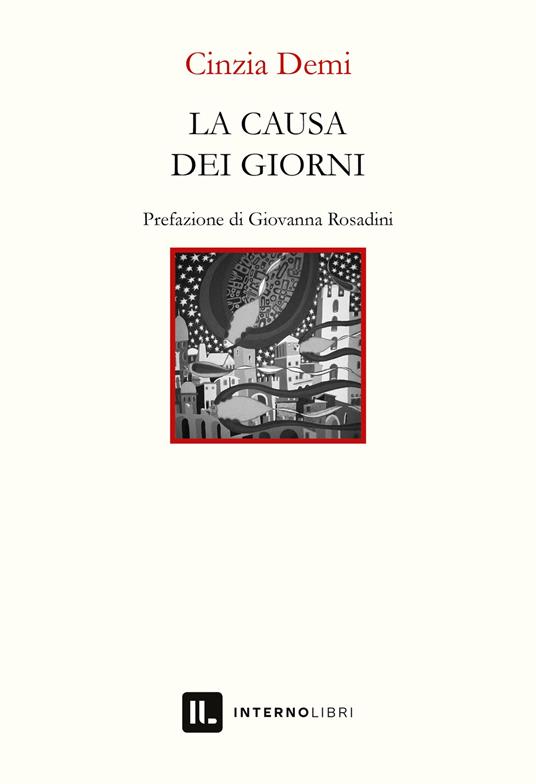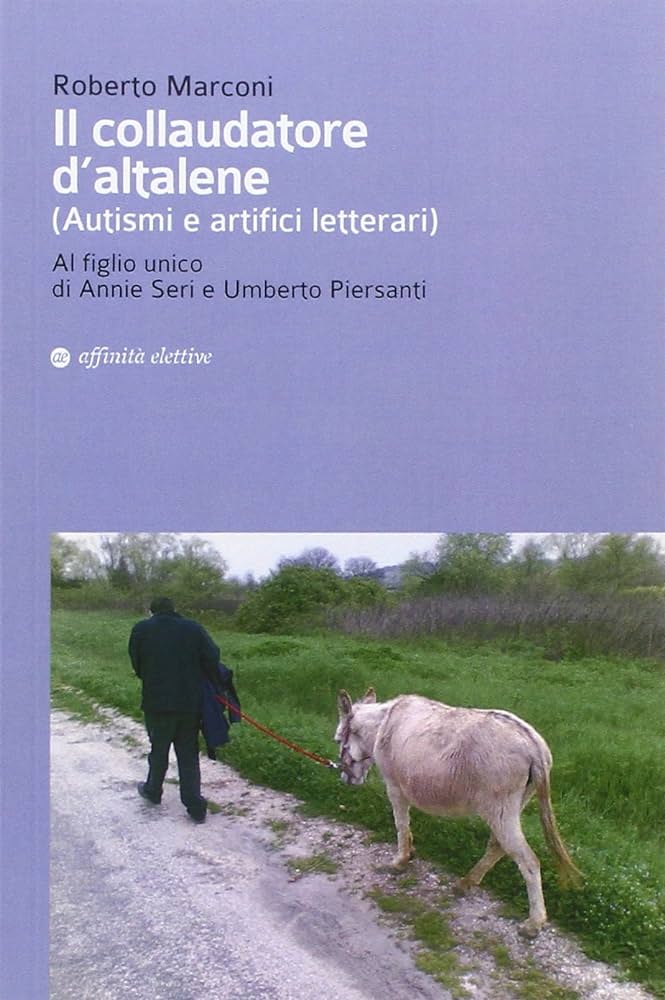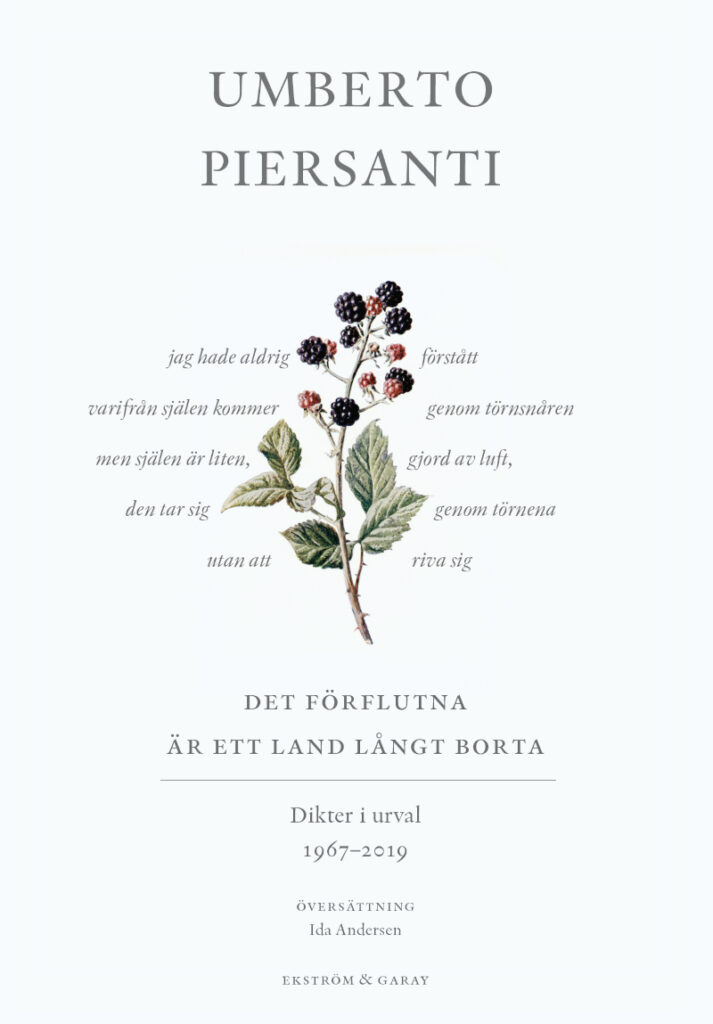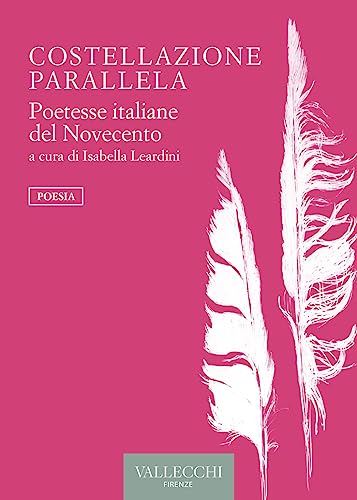Tre poesie inedite di Raffaella Bettiol

Pubblichiamo tre poesie inedite di Raffella Bettiol. Nati da un’unica radice Al margine del fiumein selva indistinta di piantedentro un solo corpo la vitadiversità tra foglie disteseacque disperse dalla pioggiaspasimi di stagioni mutevoli. In un’alba qualunque la finenel gesto gelido… Leggi tuttoTre poesie inedite di Raffaella Bettiol